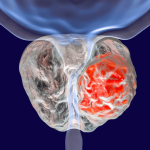Woody Allen è “cinedipendente”. Come (e più) di Clint Eastwood, da oltre 40 anni non si concede tregua. Una vocazione al set, un implacabile fiume di parole, un’infinita carrellata di sguardi, una maniacale tendenza al miscuglio di sensazioni e alla reiterazione di ossessioni: l’ebraismo, l’amore, la morte, il sesso, la (in)fedeltà, la violenza. Flussi emotivi e intellettuali che l’autore maneggia con bulimica passione per il confronto dialettico, per la delicata scansione delle fragilità. Qualcuno dice che il genio ha già dato. Altri sostengono che la vena non si sia mai inaridita, ma, al limite, serializzata. Io dico che in Cafè Society il grande Woody è corso ai ripari. Perché dopo la straordinaria doppietta di Blue Jasmine (magnifico e struggente) e Irrational Man (arguto rovesciamento della tesi di Match Point), l’artista newyorkese sapeva di dover proporre qualcosa di diverso e innovativo, anche dal punto di vista estetico. Ed ecco l’incontro (sublimato) con Vittorio Storaro, il re della fotografia pulsante. E, con lui, le visioni pastose e sensuali di quest’ultima opera, dove scene, contesti e passaggi narrativi sono caratterizzati da giochi di luce diversi: lividi e rarefatti nelle periferie basso
borghesi; calde e avvolgenti nelle patinate panoramiche hollywoodiane (da lui apertamente disprezzate, fin dai tempi di Annie Hall). Il tutto reso ancor più intenso e impattante dalle riprese in digitale, opzione tecnica che il prolifico Allen adotta per la prima volta e che contribuisce a spingere su contrasti e cromatismi. In mezzo, un tessuto testuale gravido di malinconia. Un universo in cui la doppiezza non nuoce al prossimo (persino il gangster, brutale e sanguinario, risulta irresistibilmente simpatico, proprio in funzione della propria schietta linearità), ma a se stessi, perché è proprio dall’ambiguità del “quieto vivere” che scaturiscono sacrifici dolorosi, spesso frutto di opportunismo o arrendevolezza. Mentre il regista, afflitto dal proprio ateismo, cerca nella dea Bellezza le risposte che né l’amore né l’arte riescono a fornirgli. Ed è forse per questo che, in linea con la tendenza alleniana a un romanticismo incantevole e spesso frustrato, Cafè Society si rivela carico di evitabili e ataviche rinunce, come se la felicità fosse un lusso per pochi, ignari viandanti. Come se l’esistenza fosse un sentiero disseminato di mine, trappole e tagliole. Le stesse che, nella propria fatale insidia, nascondono la salvezza dell’anima.