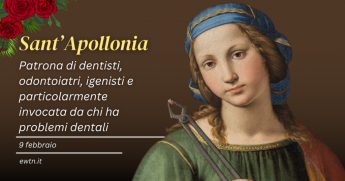Autismo e dislessia sono ormai termini noti a genitori e insegnanti. Molto meno familiare è invece il disturbo evolutivo del linguaggio (DLD), una condizione che riguarda circa un bambino su dieci in età scolare ma che spesso passa inosservata. A ricordarlo è stata la ricercatrice Anastasiia Ogneva, docente all’Universidade de Santiago de Compostela, che sulle pagine di The Conversation ha sottolineato come la scarsa conoscenza e le difficoltà diagnostiche portino il disturbo a essere confuso con immaturità, pigrizia o problemi di comportamento.
Un disturbo senza volto
Il DLD non presenta segni fisici riconoscibili, ma incide profondamente sulla vita quotidiana: limita la capacità di comprendere e utilizzare il linguaggio, ostacolando l’apprendimento scolastico e le relazioni sociali. Alcuni bambini se la cavano nelle conversazioni semplici, ma incontrano grandi difficoltà quando il linguaggio si fa più complesso, ad esempio leggendo testi scolastici o seguendo spiegazioni articolate.
A casa i genitori possono notare frasi molto brevi e incomplete (“bimbo giocare macchinina”), difficoltà a seguire istruzioni composte o scarsa capacità di raccontare episodi. Non sorprende quindi che negli anni siano cambiate più volte le definizioni del disturbo – da “specifico del linguaggio” a “misto recettivo-espressivo” – generando confusione. Solo grazie al progetto internazionale CATALISI si è arrivati a una nomenclatura condivisa.
I segnali da non sottovalutare
Ogni bambino con DLD ha un profilo diverso, ma i campanelli d’allarme includono: difficoltà nel seguire istruzioni, vocabolario ridotto, errori grammaticali persistenti, problemi nel raccontare esperienze quotidiane e, con l’ingresso a scuola, difficoltà di comprensione dei testi scritti. Non è un semplice ritardo destinato a scomparire: senza intervento, può compromettere autostima, rendimento scolastico e inclusione sociale.
Come distinguerlo da dislessia e autismo
Il DLD non va confuso con altri disturbi. A differenza della dislessia, dove il problema principale è la decodifica delle parole scritte, qui il bambino può leggere correttamente senza però comprendere il significato del testo. Diverso anche dall’autismo, poiché i bambini con DLD mantengono capacità sociali e intenzione comunicativa, pur con un linguaggio limitato.
Le conseguenze e gli strumenti di supporto
Le difficoltà del DLD spesso accompagnano i ragazzi nell’adolescenza e in età adulta, con un rischio maggiore di abbandono scolastico e difficoltà lavorative. Tuttavia, una diagnosi precoce e un supporto mirato fanno la differenza. Logopedia, supporti visivi, adattamenti scolastici e la collaborazione tra scuola e famiglia sono strumenti essenziali.
In classe può essere utile semplificare le istruzioni, integrare schemi e immagini, concedere più tempo per i compiti. A casa, invece, i genitori possono leggere quotidianamente con i figli, ampliare le loro frasi e stimolarli al racconto. Secondo Ogneva, intervenire già a 4-5 anni aumenta enormemente le probabilità di successo, mentre a 9-10 anni le frustrazioni scolastiche rischiano di essere già consolidate.
Il messaggio è chiaro: riconoscere il disturbo in tempo non significa solo migliorare le competenze linguistiche, ma dare a questi bambini la possibilità di crescere sicuri, inclusi e pronti ad affrontare il futuro.