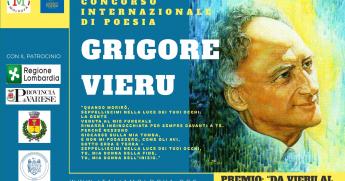Due donne forti e volitive, due figure di spicco nell’Ottocento romantico non soltanto varesino, Giuseppina e Felicita hanno incarnato da un lato l’arte del canto, assoluta e inafferrabile, e dall’altro il patriottismo risorgimentale e la delicata missione dell’educatrice.
Giuseppina Grassini nacque a Varese il 18 aprile 1773 in una famiglia numerosa ma non indigente. Il padre era economo al monastero di Santa Maria del Monte, la madre, violinista dilettante, insegnò alla bambina le prime nozioni musicali, completate poi da Domenico Zucchinetti, maestro di cappella in San Vittore. Bellissima e altera, la ragazza diventa presto allieva di Antonio Secchi a Milano, complice il conte Alberico Belgiojoso, grande amatore di canto.

Giuseppina Grassini
La Grassini era donna da far girar la testa al mondo, a sedici anni debuttava a Parma con “La pastorella nobile” di Guglielmi e l’anno successivo alla Scala, ma il genere comico non le si addiceva, visto il suo temperamento ardente che avrebbe fatto perdere la testa a Napoleone, colpito e affondato durante una recita alla Scala ne “La vergine del sole” di Andreozzi, poco prima della battaglia di Marengo, anno 1800.
Josephine, mezzosoprano dal timbro caldo e morbido,
era allora al suo apice, cantava con un’altra star dell’epoca, il castrato Crescentini, e Nicola Zingarelli aveva scritto per lei “Giulietta e Romeo”, andata in scena sempre alla Scala il 30 gennaio 1796.
Ormai parigina e amante anche del violinista Pierre Rode, la Grassini ebbe trionfi inglesi al King’s Theatre di Londra, e duellò in gorgheggi con un’altra primadonna del tempo, Elizabeth Billington, pure bellissima ma meno virtuosa.
Inquieta e civettuola, Giuseppina intrecciò una relazione con il “nemico”, il duca di Wellington, e dopo la Restaurazione fu costretta da Luigi XVIII a lasciare la Francia, ritornò a Milano ma ormai il suo astro era al tramonto. Morì a Milano nel 1850, dopo aver dispensato la sua arte ad allieve straordinarie quali Giuditta Pasta e le nipoti Giulia e Giuditta Grisi.
Felicita Morandi, nata a Varese il 21 aprile 1827, dopo gli studi a Monza e Milano, partecipò ventunenne, travestita da uomo, ai moti del ’48, dimostrando un forte spirito battagliero e spingendo le donne alla mobilitazione. Lettrice appassionata di Manzoni, Cantù, Tommaso Grossi e Giuseppe Giusti, insofferente alla disciplina scolastica –lei che sarebbe diventata una perfetta educatrice- si trasferì con la famiglia a Milano nel 1852, iniziando a tradurre testi dal francese, per poi spostarsi a Parma.

Felicita Morandi
La sua carriera di educatrice delle giovani più sfortunate incominciò nel 1862, e tre anni dopo Felicita Morandi si sarebbe di nuovo trasferita a Milano, alla direzione dell’Orfanotrofio femminile della Stella, nel quale introdusse importanti riforme, preparando le giovani all’ingresso nel mondo del lavoro con corsi di formazione dedicati alla legatoria di libri e alla sartoria.
Autrice prolifica di manuali e romanzi moralistici, incominciò pubblicando a Varese, tra il 1857 e il ’59, due raccolte poetiche, per poi scrivere commedie, proverbi e libri di lettura per le scuole, e perfino un diario di viaggio in Italia, “Da Torino a Napoli”, dato alle stampe nel 1890 in un’edizione di lusso da Gnocchi di Milano.
Dopo una parentesi romana con la riorganizzazione dell’Orfanotrofio di Termini, nel 1879 diventa ispettrice degli educatori femminili dell’alta Italia, carica mantenuta per cinque anni, prima di dedicarsi alla Pensione benefica di Milano, nata all’interno delle Stella e destinata ad accogliere ragazze orfane e lavoratrici arrivate dalla campagna. L’allieva Fulvia Saporiti ne curò i “Ricordi postumi” pubblicati nell’anno stesso della morte, avvenuta a Milano nel 1906.